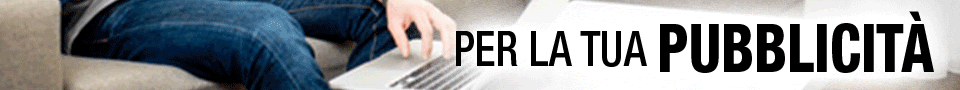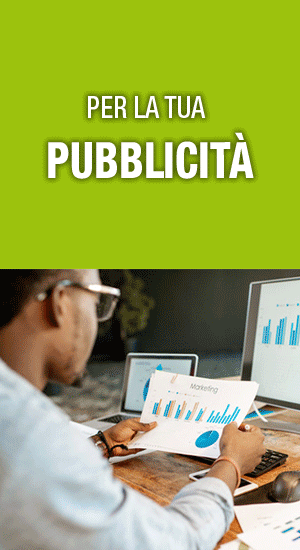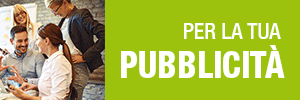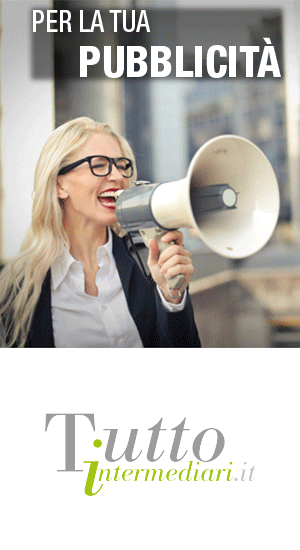I nuovi parametri richiesti alle compagnie nell’ambito della solvibilità patrimoniale riaccendono il dibattito su questo comparto che, a oggi, non ha trovato una soluzione che possa accontentare tutti: pubblico, privato e i cittadini.
 Da quest’anno, le compagnie sono tenute a effettuare una quantificazione dell’entità dei rischi catastrofali valutandone l’impatto ai fini della propria solvibilità patrimoniale. Solvency II, infatti, stabilisce che debba essere valutato, e formalmente descritto in un apposito sottomodulo (danni e vita), l’impatto del rischio catastrofale sul fabbisogno di capitale dell’impresa (i rischi da catastrofe naturale, secondo Solvency, sono: tempesta, terremoto, alluvione, grandine e cedimento, frane).
Da quest’anno, le compagnie sono tenute a effettuare una quantificazione dell’entità dei rischi catastrofali valutandone l’impatto ai fini della propria solvibilità patrimoniale. Solvency II, infatti, stabilisce che debba essere valutato, e formalmente descritto in un apposito sottomodulo (danni e vita), l’impatto del rischio catastrofale sul fabbisogno di capitale dell’impresa (i rischi da catastrofe naturale, secondo Solvency, sono: tempesta, terremoto, alluvione, grandine e cedimento, frane).
La compagnia deve pertanto disporre di un capitale tale da risultare sufficiente a far fronte alle obbligazioni nei confronti dei propri assicurati nei successivi 12 mesi, con una probabilità del 99,5%. Nel calcolo di solvibilità si dovrà tenere conto della diversificazione del portafoglio, in termini geografici e di tipologia dei rischi assunti, nonché delle quote retrocesse e degli eventuali limiti all’indennizzo (scoperti e franchigie).
A ricordare tutto questo è l’Ivass che recentemente ha effettuato una rilevazione statistica su un campione significativo di imprese, da cui è emerso che, nel 2014, i premi relativi alle coperture dei rischi catastrofali sono pari all’1,6% del complesso della raccolta premi nei rami danni registrata dalle imprese del campione, con una percentuale di retrocessione ai riassicuratori pari al 31,3%.
Secondo una stima fornita da Eiopa, che impiega un indicatore acquisito dalla società di riassicurazione Munich Re, l’incidenza dei sinistri catastrofali sulla raccolta premi complessiva è stata nel 2014, in tutta Europa, pari al 2,5%. Sul campione analizzato dall’Ivass, invece, questo rapporto nel 2014 risulta essere dell’1%.
IL RICORSO AI CAT BOND – Il rischio di insolvenza prodotto dall’acquisizione di coperture assicurative in questo specifico comparto, fa presente l’istituto di vigilanza, può essere superato con l’utilizzo dei catastrophe bond (cat bond), che consentono di aumentare la capacità di sottoscrizione facendo ricorso al mercato dei capitali attraverso la cartolarizzazione del rischio catastrofale. Con l’emissione (da parte di una compagnia assicurativa, riassicurativa o dello Stato) e il collocamento di questi strumenti si va a redistribuire una parte dell’esposizione relativa ai rischi catastrofali su una base molto vasta di soggetti, con elevata predisposizione al rischio e alla ricerca di elevati rendimenti. Il rischio assicurativo viene così trasformato in rischio finanziario.
I cat bond vengono emessi a un valore nozionale che verrà rimborsato a scadenza (solitamente 3-5 anni) se la catastrofe connessa non si è verificata; in caso contrario, il nozionale verrà rimborsato in parte, o non rimborsato, perché utilizzato per coprire i danni della catastrofe. Proprio per lo scarso ricorso all’assicurazione dei rischi per catastrofi naturali, ha ricordato l’Ivass, in Italia il mercato dei cat bond non si è ancora sviluppato.
LE CRITICITA’ DEL SISTEMA ITALIANO E POSSIBILI SOLUZIONI – Il modello utilizzato in Italia fino a oggi si è basato su finanziamenti statali deliberati dopo il verificarsi della catastrofe, con la relativa incertezza sull’entità e sull’effettivo conseguimento del risarcimento, tempistiche eccessivamente lunghe, erogazioni poco trasparenti con possibili allocazioni inefficienti, scarsità degli incentivi per investimenti in prevenzione.
Da molti anni si discute sull’introduzione di un sistema assicurativo misto pubblico-privato che incentivi la copertura dei rischi catastrofali da parte dei cittadini; ciò, secondo l’Ivass, avrebbe il pregio di mitigare i fenomeni antiselettivi e fornire, grazie all’intervento dello Stato, la capacità finanziaria necessaria per far fronte agli eventi che dovessero arrecare danni superiori a quelli sostenibili dal solo sistema privato. Il settore assicurativo privato metterebbe a disposizione le proprie competenze riguardo la valutazione e liquidazione dei danni.
L’istituto di vigilanza ha anche classificato le varie forme di intervento statale che si possono adottare, fermo restando che non essite «un modello preferibile rispetto agli altri e che questi possono anche combinarsi tra loro»:
- Interventi ex- post – copertura pubblica dei danni (con risarcimenti parziali o totali). Il modello non prevede la necessità di adottare misure di prevenzione ex-ante da parte dello Stato, ma, dopo che l’evento catastrofale si è verificato, lo Stato deciderà se, e in quale misura, coprire i danni prodotti. Questa tipologia di intervento è molto rischiosa sia per lo Stato che per i cittadini colpiti dall’evento catastrofale in quanto l’ammontare del danno prodotto sarà una spesa aleatoria, così come lo sarà la capacità di copertura dello Stato. Questo è il modello finora utilizzato dall’Italia.
- Interventi ex- ante – attraverso la mutualità pubblica: si realizza una riallocazione ex-ante dei rischi fra tutti i cittadini, attraverso regole di copertura (parziale o totale) dei danni in caso di eventi catastrofali, tramite la realizzazione di opere pubbliche destinate alla prevenzione degli eventi o dei loro effetti nonché attività di sensibilizzazione nelle popolazioni a rischio e predisposizione di piani di emergenza.
- Incentivi all’assicurazione dei rischi catastrofali: le compagnie assicurative possono essere lasciate libere nello svolgimento della loro attività (sottoscrizione polizze, raccolta premi, valutazione sinistri, ecc.), tuttavia, qualora il cittadino non riesca a trovare sul mercato una copertura assicurativa o la trovi a prezzi eccessivi, lo Stato interviene fissando i criteri per l’assunzione del rischio o attraverso la corresponsione di sussidi che rendano il premio non troppo elevato. Lo Stato può intervenire anche attraverso l’istituzione di un fondo pubblico che supporti le perdite non previste dalle stesse imprese. Un esempio di tale modello è rinvenibile in Belgio.
- Collaborazione con le compagnie di assicurazione: attraverso la propria rete, il settore privato si assume ex-ante i rischi che poi verranno retrocessi (in tutto o in parte) allo Stato, il quale assume un ruolo di riassicuratore di ultima istanza. Il mercato privato, tuttavia, risulta generalmente vincolato in quanto lo Stato impone una standardizzazione dei contratti e ne fissa i prezzi. In tale modello i danni più severi e imprevedibili sono a carico dello Stato mentre il comparto privato copre un livello di danni “normale” e garantisce i servizi connessi all’attività di assunzione e liquidazione.
Fabio Sgroi
© RIPRODUZIONE RISERVATA