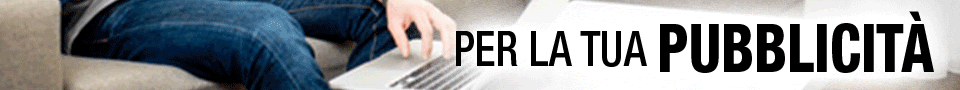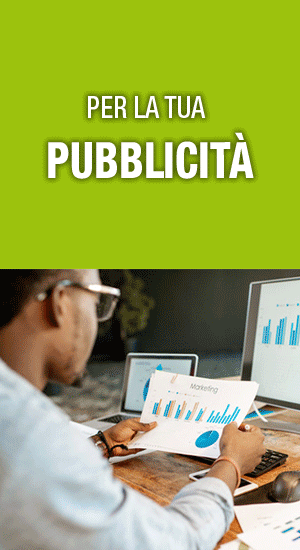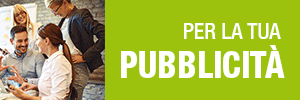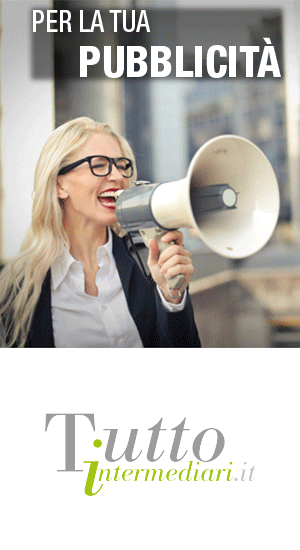In questa intervista concessa a Tuttointermediari.it, gli avvocati Giorgio Grasso e Alessia Keissidis, rispettivamente senior partner e of counsel di Btg Legal, hanno approfondito il tema.

Nell’ultimo periodo sempre più spesso si parla del whistleblowing, l’istituto di derivazione anglosassone, disciplinato a livello europeo dalla direttiva Ue 2019/1937 (a cui l’Italia ha dato attuazione con il dl.gs 10 marzo 2023 n.24), che offre tutela alle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione o di normative nazionali, che ledono (o si ha il sospetto che ledano) l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’ente, con cui il segnalante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore.
La questione, e poi vedremo il perché, riguarda anche il settore assicurativo e anche gli intermediari assicurativi. Tuttointermediari.it ha approfondito l’argomento con gli avvocati Giorgio Grasso e Alessia Keissidis, rispettivamente senior partner e of counsel di Btg Legal. Grasso, in particolare, ha ricordato come la misura non riguardi «solo i dipendenti, ma anche per esempio, i consulenti, volontari, azionisti, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo».
Domanda. Come avviene la segnalazione?
Grasso. Per tutelare le persone che comunicano le violazioni, il decreto, nel recepire le indicazioni della direttiva Ue, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni. La preferenza accordata ai canali interni dell’ente tenuto all’obbligo normativo si evince dal fatto che, solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, i segnalanti possono fare ricorso al “canale esterno” attivato presso Anac (Autorità nazionale anticorruzione, ndr). Rimane naturalmente salvo il dovere di rivolgersi all’autorità giudiziaria ove ne ricorrano i presupposti. Grazie all’attività dei “whistleblower” è pertanto possibile prevenire pericoli, ad esempio quelli legati alle truffe o alla salute, e informare i potenziali soggetti a rischio prima che si verifichi il danno effettivo.
D. Il whistleblowing riguarda anche il settore assicurativo e quindi anche gli intermediari?
Keissidis. Per rispondere alla domanda occorre procedere a un’accurata esegesi del testo del decreto, analizzandone il rapporto sussistente con la normativa di settore (in particolare, gli articoli 10-quater e 10-quinquies del Codice delle Assicurazioni Private in vigore dal 1°ottobre 2018). L’attività dell’interprete, va osservato, non è di certo agevolata dalla tecnica utilizzata dal legislatore, che costringe a continui rinvii e riscontri con gli atti legislativi richiamati negli allegati al decreto, per verificare quali sono le specifiche normative (nazionali o comunitarie) richiamate nell’allegato ed, eventualmente, escluse dall’ambito oggettivo di applicazione. Il decreto, infatti, ha incluso, nel suo ambito di applicazione soggettiva, anche gli enti di diritto privato. Rispetto alla precedente normativa si tratta di una più ampia categoria di enti specificamente individuati con riferimento a diversi criteri, relativi alla consistenza del personale, all’adozione o meno del Mog 231, nonché allo svolgimento di (specifiche) attività nei settori disciplinati dal diritto dell’Ue. Con riferimento a quest’ultimo criterio sono sorte alcune questioni interpretative. Dal dato testuale del decreto, l’applicazione agli intermediari assicurativi, a prescindere dal numero di dipendenti, risulta previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera q), n. 2 del decreto, che estende i vincoli a tutti i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione di una vasta serie di atti di derivazione europea, elencati nell’allegato al decreto. Tra questi figura anche il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, che reca attuazione della direttiva (Ue) 2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa (e pertanto riguarda anche gli intermediari assicurativi).
 D. Quale è, quindi, il rapporto tra la normativa di portata generale e quella di settore?
D. Quale è, quindi, il rapporto tra la normativa di portata generale e quella di settore?
Keissidis. Dall’analisi testuale del decreto risulta che la normativa di settore non è stata implicitamente abrogata e che anzi è dotata di piena autonomia rispetto a quella generale. Il primo punto è supportato dal dato testuale del decreto, che esclude dal proprio ambito di applicazione (articolo 1, comma 2, lettera b) le segnalazioni di violazioni «già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto…». Il secondo punto è avvalorato dall’espressa attribuzione all’Ivass del potere di emanare disposizioni attuative in materia (articoli 10-quater, comma 4, e 10-quinquies, comma 1, lettera b del Codice). A tal fine, Ivass ha pubblicato lo schema di regolamento (documento n. 5/2019), ancora in consultazione che, nel disciplinare la materia del whistleblowing, persegue come obiettivi principali: la creazione di canali dedicati che assicurino la riservatezza sull’identità del segnalante e del segnalato; il rispetto del principio di proporzionalità̀ applicato alla singola realtà operativa per adattare il sistema di segnalazioni delle violazioni alla struttura organizzativa e alle attività̀ svolte; l’individuazione del responsabile interno all’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o dell’intermediario, deputato ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure; la determinazione delle procedure da seguire nel caso in cui sussistano le condizioni per effettuare le segnalazioni. Alla luce di ciò, gli intermediari assicurativi risultano quindi destinatari, oltre che delle previsioni del D. Lgs. n. 24/2023, anche delle norme sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni, previsti dal Codice delle Assicurazioni.
D. Quali obblighi hanno gli intermediari assicurativi?
Keissidis. A prescindere dal numero di addetti (il decreto, stando al suo tenore letterale, vincola tutte le società private a prescindere dalle loro dimensioni) hanno l’obbligo di dotarsi del canale interno per la segnalazione delle violazioni «di normative Ue o di normative nazionali che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente», nonché di incaricare una persona, un apposito ufficio o un soggetto esterno della gestione dello stesso.
Grasso. Aggiungo che gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi quelli a titolo accessorio, hanno l’obbligo di adottare procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l’attività assicurativa e riassicurativa svolta. Tuttavia, per quanto riguarda l’applicabilità della citata normativa di settore, non è chiara la concreta individuazione dei destinatari con riferimento al criterio dimensionale (ossia, se gli intermediari di piccole dimensioni siano o meno esonerati dall’obbligo normativo di settore). Infatti, il relativo regolamento attuativo dell’Ivass, come detto ancora in consultazione, invocando il principio di proporzionalità, fa una distinzione dimensionale degli intermediari destinatari dei relativi obblighi, prevedendo un “regime base” per gli intermediari con più di 30 addetti, un “regime ridotto” per gli intermediari con un numero di addetti compreso fra 10 e 30 e concedeva agli intermediari costituiti in forma di società di capitali e gli intermediari See, a prescindere dalla forma giuridica, che operano in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, con personale inferiore a 10 unità, nonché agli intermediari persone fisiche o costituiti in forma di società di persone, la possibilità di utilizzazione del canale esterno di segnalazione gestito dal medesimo istituto, esonerandoli dall’obbligo di adozione di quello interno.
 D. Quindi?
D. Quindi?
Grasso. Al momento non è pertanto possibile stabilire se verrà mantenuta o meno dall’Ivass la suddetta distinzione in termini dimensionali dei soggetti obbligati. In caso affermativo, l’esonero per i piccoli intermediari riguarderebbe solo la segnalazione delle violazioni delle norme disciplinanti l’attività assicurativa e riassicurativa svolta (articolo 10-quater del Codice), mentre per le violazioni di portata generale (violazioni delle normative Ue o nazionale che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente), se non disposto diversamente, trova piena applicazione il decreto che non opera distinzioni dimensionali.
D. Intravvede delle criticità per gli intermediari?
Keissidis. Occorre cambiare il punto di vista e non vedere l’entrata in vigore del decreto come una “criticità”, bensì come una opportunità. L’attività di whistleblowing, se radicata a tutti i livelli della società e ovviamente tutelata, offre l’opportunità di un maggiore progresso dell’intermediario e di una corretta implementazione del sistema di controllo interno della stessa società. Il whistleblowing è quindi un importante e utile strumento di compliance aziendale, massimizzandone la piena efficacia. Per fare ciò, gli intermediari dovranno assicurarsi che tale strumento sia facilmente utilizzabile, tuteli la riservatezza di tutti i segnalanti, garantisca il monitoraggio e la gestione delle segnalazioni e preveda interventi rapidi ed efficaci a fronte delle eventuali comunicazioni. A ciò si aggiunga il consiglio di evitare “standardizzazioni” che, come noto, non sono viste con favore dalle autorità di vigilanza, trattandosi, come in questo caso, di modelli operativi da adeguare alla peculiare organizzazione e struttura dell’ente. Pertanto, il consiglio è di affidarsi a dei consulenti che facciamo un esame effettivo delle esigenze/doveri del cliente.
D. Cosa rischiano gli intermediari che non si adeguano?
Grasso. Alla luce della coesistenza dei due impianti normativi (generale e di settore), i rischi sono essenzialmente legati all’impianto sanzionatorio previsto dalle rispettive normative che vede Anac competente sia per le ispezioni, sia per le sanzioni nell’ambito della normativa di portata generale (il decreto) e Ivass per la normativa di settore. In verità, sarebbe auspicabile un’armonizzazione tra le due discipline e che l’Ivass fornisca indicazioni specifiche agli operatori del settore (armonizzazione ancor più necessaria, al fine di evitare, per esempio, una duplicazione di attività per gli operatori del settore). È evidente che, soprattutto per gli intermediari di piccole dimensioni, ciò potrebbe costituire un onere gravoso dal punto di vista organizzativo e sproporzionato rispetto alla propria effettiva struttura.
Fabio Sgroi
© RIPRODUZIONE RISERVATA