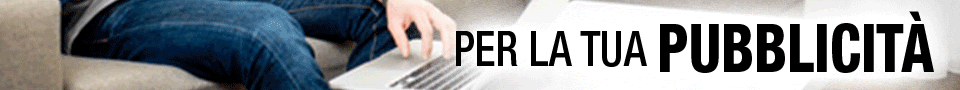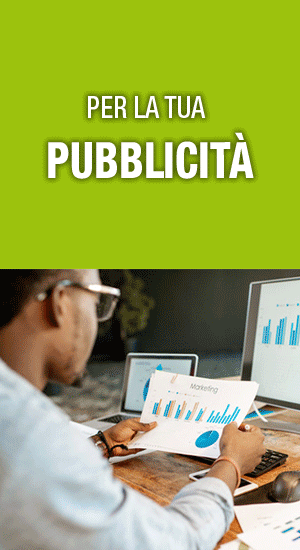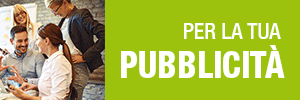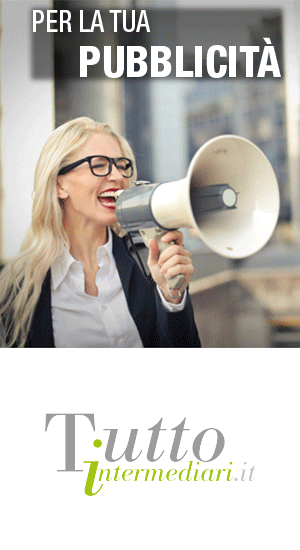Marco Rossetti, giudice della Corte di Cassazione, è convinto che uno degli ostacoli alla diffusione della cultura assicurativa e all’approccio della stipula di coperture assicurative sia anche questo. E lancia un appello…

Uno degli ostacoli alla diffusione della cultura assicurativa e all’approccio della stipula di coperture assicurative? Per Marco Rossetti, giudice della Corte di Cassazione, è la tecnica scrittoria dei contratti e dei clausolari generali a essi allegati. Il suo intervento all’ultimo convegno nazionale dell’Aiba, l’Associazione italiana brokers di assicurazioni e riassicurazioni, ha fatto molto discutere.
Il giudice ha sì evidenziato come sia «vero» il fatto che il codice delle assicurazioni «tuoni solennemente» che i contratti di assicurazione «debbano essere chiari, ma quello di chiarezza è un concetto sintetico a posteriori e non analitico a priori». In sostanza, «quello che può essere chiaro per un individuo può essere oscuro per qualcun altro e viceversa».
Rossetti, tra l’altro, ha fatto anche qualche esempio: «L’imprenditore che da anni stipula polizze assicurative fideiussorie e sa bene di che cosa si tratta avrà bisogno di un certo tipo di informazioni, ma il neo laureato o il libero professionista o la coppia di sposi che sottoscrivono la polizza sulla casa appena acquistata hanno un livello di competenze ben diverso e necessitano sicuramente di maggiori informazioni. E dunque il contratto assicurativo che è chiaro per il primo potrebbe non esserlo per i secondi».
Il giudice si è addentrato su come sono scritti i contratti di assicurazione e i loro clausolari, sottolineando un aspetto preoccupante: «La metà delle controversie che arrivano in Corte di Cassazione riguarda l’interpretazione dei contratti, vuoi perché questi sono oscuri, vuoi perché risultano ambigui, vuoi perché addirittura contengono una nullità sostanziale».
 Ancora oggi, ha continuato Rossetti, i contratti di assicurazione «esprimono la descrizione del rischio con formule vecchie, e in qualche caso di secoli, che non rispondono più al mutato quadro dell’ordinamento giuridico. Un esempio? La polizza di copertura della Rc: ancora oggi l’assicuratore, si legge nel contratto, si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare a terzi per danni a cose, morte o lesioni. Una descrizione del rischio così concepita lascia fuori quell’enorme area dei danni non patrimoniali diversi da quelli derivanti da morte o lesioni che negli ultimi 50 anni la giurisprudenza ha creato».
Ancora oggi, ha continuato Rossetti, i contratti di assicurazione «esprimono la descrizione del rischio con formule vecchie, e in qualche caso di secoli, che non rispondono più al mutato quadro dell’ordinamento giuridico. Un esempio? La polizza di copertura della Rc: ancora oggi l’assicuratore, si legge nel contratto, si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare a terzi per danni a cose, morte o lesioni. Una descrizione del rischio così concepita lascia fuori quell’enorme area dei danni non patrimoniali diversi da quelli derivanti da morte o lesioni che negli ultimi 50 anni la giurisprudenza ha creato».
Altro esempio: «Ancora oggi vi sono contratti nei quali compaiono clausole non solo sintatticamente insignificanti, ma addirittura ritenute nulle dalla Corte di Cassazione. Prendiamo la polizza danni con la clausola di accidentalità. L’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato dai danni accidentali, ma un danno o è voluto o non è voluto. Se è voluto basterà l’articolo 1900 codice civile che esclude la copertura, se non è voluto, cioè accidentale, è dovuto al caso e se è dovuto al caso scatta la copertura. Non c’è una terza possibilità fra danni voluti, danni non voluti e danni non voluti accidentali…».
Il giudice ha fatto riferimento anche alle polizze D&O (directors & officers liability”), quelle che proteggono il patrimonio personale degli amministratori e dei membri degli altri organi di gestione (amministratori, direttori, dirigenti, sindaci ed eventuali membri del consiglio di sorveglianza) nei casi in cui vengono chiamati in causa per risarcimento danni. In alcuni casi «hanno dei clausolari tratti alla lettera da polizze britanniche o statunitensi, cioé da sistemi giuridici che prevedono norme fondanti la responsabilità di amministratori e sindaci completamente diverse dalle nostre».
Per Rossetti è arrivato il momento di avviare «una seria e ampia riflessione su come vengono scritti i contratti e con quale intento. L’intento deve essere quello di far capire all’assicurato di che discutiamo e non quello di nascondere un codicillo da tirar fuori poi al momento in cui si verifica il rischio. E dovrebbe essere una riflessione che coinvolga tutti gli addetti ai lavori e quindi non solo i manager, gli imprenditori, i giuristi, gli avvocati e i magistrati, ma anche i linguisti, i filologi e i tecnici».
Fabio Sgroi
© RIPRODUZIONE RISERVATA