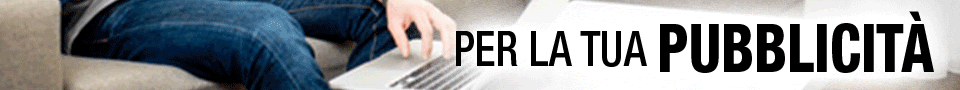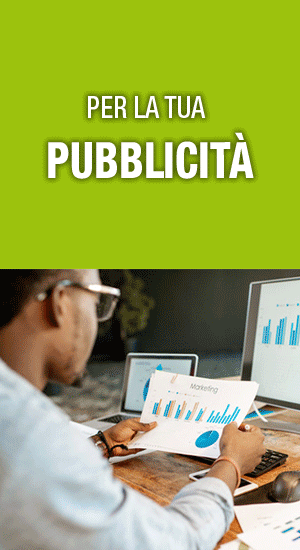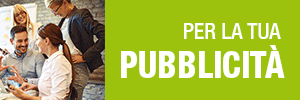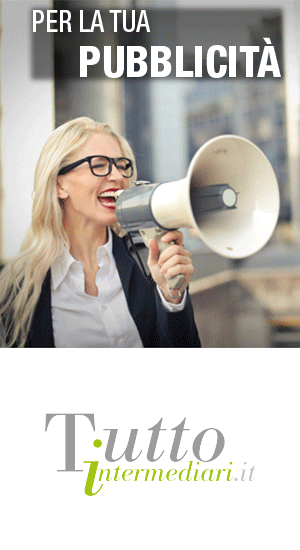Il tema è stato al centro del primo appuntamento del 2025 del Laboratorio degli intermediari del Cesia (Centro studi intermediazione assicurativa). In particolare si è cercato di rispondere a diversi interrogativi…
 La Legge di Bilancio 2024 che ha reso obbligatoria per tutte le imprese l’assicurazione contro il rischio di catastrofi naturali? Ha aperto un nuovo fronte per gli intermediari assicurativi. Da un lato rappresenta sì una opportunità per lo sviluppo del business, ma dall’altro è anche una fonte di rischio, soprattutto nella fase iniziale di applicazione.
La Legge di Bilancio 2024 che ha reso obbligatoria per tutte le imprese l’assicurazione contro il rischio di catastrofi naturali? Ha aperto un nuovo fronte per gli intermediari assicurativi. Da un lato rappresenta sì una opportunità per lo sviluppo del business, ma dall’altro è anche una fonte di rischio, soprattutto nella fase iniziale di applicazione.
Questo tema è stato al centro del primo appuntamento del 2025 (foto sopra) del Laboratorio degli intermediari del Cesia (Centro studi intermediazione assicurativa), che si è riunito qualche settimana fa. In particolare si è cercato di rispondere a diversi interrogativi. Per esempio: come valutare correttamente l’esposizione delle singole imprese? Come costruire polizze economicamente sostenibili per le imprese e le compagnie che devono assicurarle (l’obbligo vale per entrambe le parti)? Quale ruolo sono chiamati a svolgere gli intermediari? Quali sono i maggiori rischi nella fase di transizione?
Ai lavori, che sono stati introdotti da Massimo Michaud, coordinatore del Cesia, sono intervenuti Dario Focarelli, direttore generale dell’Ania e vice presidente di Cineas, e Federico Carturan, fondatore e amministratore delegato di RiskApp, società specializzata nella valutazione dei rischi.
Il confronto con gli intermediari è stato alimentato dai componenti del comitato scientifico del Cesia: Sandro Amorosino, presidente, professore straordinario di diritto amministrativo all’Università Uninettuno, già ordinario di diritto dell’economia all’Università Sapienza di Roma; Patrizia Contaldo, professore di economia delle polizze vita e dei fondi pensione e direttore dell’osservatorio sul mercato assicurativo dell’Università Bocconi; Sara Landini, ordinario di diritto dell’economia e docente di diritto delle assicurazioni all’Università degli Studi di Firenze; Pierpaolo Marano, professore di diritto delle assicurazioni e di diritto commerciale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

«L’introduzione dell’obbligo assicurativo contro il rischio di catastrofi naturali è un importante passo in avanti per il nostro Paese oltre che un’opportunità per il mercato assicurativo», ha sottolineato Focarelli. «Questa legge segna l’inizio di un processo evolutivo e, proprio perché si tratta di un inizio, pone tutti gli attori di fronte a molte difficoltà». I professionisti dell’intermediazione assicurativa? «Hanno un ruolo centrale in questo percorso e nel successo del suo esito», ha evidenziato sempre Focarelli. «Hanno un compito decisivo: convincere milioni di imprenditori che, mai come oggi, l’assicurazione è uno scudo necessario per il loro business».
Per Contaldo, gli intermediari italiani «possono rappresentare il vero motore del cambiamento nella prevenzione dei rischi collegati al cambiamento ambientale. L’incompletezza dei riferimenti normativi, che oggi impedisce alle compagnie di perfezionare l’offerta, è un elemento di complessità, ma il potenziale di sviluppo è molto interessante».
La letteratura accademica, ha continuato Contaldo, «suggerisce di guardare con attenzione all’esperienza di Paesi (per esempio, il Marocco e alcuni Paesi caraibici) che, a livello sistemico, hanno adottato micro-assicurazioni parametriche per la popolazione a basso reddito con accesso limitato o nullo al mercato assicurativo tradizionale. Le coperture previste da questi programmi sono semplici e destinate alla sola protezione contro rischi critici, con premi bassi e i limiti assicurativi proporzionalmente ridotti. Una soluzione simile potrebbe essere adottata anche in Italia integrandola con le polizze tradizionali. Rimane fondamentale, in ogni caso, l’educazione alla gestione del rischio. L’intermediario ha, in questo senso, un ruolo centrale: il presidio che esercita sul territorio lo pone nelle condizioni ideali per offrire consulenza sulla prevenzione, sulle soluzioni di adattamento e sul monitoraggio continuo del rischio».
Il pensiero di Landini è questo: «In questi anni abbiamo assistito a un’accelerazione della capacità delle compagnie di mappare e monitorare i rischi climatici delle imprese. Oggi, però, è anche importante mappare gli adattamenti possibili per fronteggiare i rischi. Ci troviamo, con tutta evidenza, in una situazione di difficile sostenibilità economica, sia per le compagnie sia per le imprese. Questo rende necessario valorizzare le tecniche di adattamento applicate dalle imprese per ridurre l’esposizione al rischio, la sola strada praticabile per contenere il costo del premio o limitare le franchigie».

Le piattaforme tecnologiche digitali? «Possono essere un valido supporto al lavoro degli intermediari, per diverse ragioni», ha rimarcato Landini. «Anzitutto, per valutare l’impatto degli adattamenti e, quindi, consentire di proporre contratti economicamente sostenibili e offrire un servizio di gestione del rischio immediatamente valorizzabile dal cliente. Inoltre, non meno importante, le piattaforme possono facilitare l’attività educativa sul rischio climatico che gli intermediari sono chiamati a svolgere per migliorare la copertura assicurativa delle imprese. L’integrazione delle piattaforme digitali nell’attività degli intermediari non deve tuttavia eliminare la componente fisica della relazione con l’impresa cliente. La parola chiave, oggi, è phygital, la combinazione tra distribuzione fisica e digitale».
Marano si è concentrato sui potenziali rischi per gli intermediari. «Il differimento dell’obbligo assicurativo ha aperto una fase transitoria di difficile gestione. Come si dovrebbe comportare, per esempio, un intermediario, che fosse chiamato a rinnovare la polizza di un’impresa coperta solo parzialmente rispetto ai nuovi obblighi assicurativi sulle catastrofi naturali? Può proporre di rinnovare la polizza con quelle carenze, oppure proporre una polizza più completa? La situazione è potenzialmente rischiosa. Se proponesse il rinnovo con le stesse coperture della polizza precedente, un eventuale sinistro potrebbe originare la responsabilità dell’intermediario perché la compagnia, proprio per gli obblighi appena introdotti, è certamente dotata del prodotto adeguato al rischio meteo-climatico che prima non era possibile soddisfare. Appare pertanto opportuno, sotto il profilo probatorio e ai fini di una corretta rendicontazione dell’attività svolta, che l’eventuale volontà del cliente di non aderire al prodotto conforme ai nuovi obblighi assicurativi (sebbene regolarmente proposto dall’intermediario) sia formalizzata per iscritto anche nel caso di una vendita senza consulenza».
Per altro verso, ha continuato Marano, «la mera offerta di un prodotto conforme agli obblighi di legge non esonera l’intermediario dall’obbligo di condurre un’accurata analisi dei bisogni assicurativi del cliente. In particolare, in contesti quali i rapporti con gli istituti bancari o la pubblica amministrazione, il cliente potrebbe necessitare di una copertura più ampia rispetto alle garanzie minime previste dalla normativa. Questo richiederebbe all’intermediario un approccio che non limitato al mero assolvimento dell’obbligo di legge ma orientato all’effettiva coerenza del prodotto offerto rispetto alle specifiche esigenze del cliente».
Per Carturan, la consulenza degli intermediari alle imprese sulle polizze cat nat «può essere efficacemente sostenuta dagli strumenti digitali. La capacità dei sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati permette oggi di costruire un quadro dettagliato della situazione di ogni singola impresa e dei possibili impatti economici provocati da eventi climatici avversi. Il quadro include sia i dati sull’ambiente in cui l’impresa opera (quindi i fenomeni atmosferici dell’area geografica e le probabilità di accadimento), sia i dati sull’attività economica, il valore patrimoniale degli asset e i costi per un eventuale ripristino». (fs)
© RIPRODUZIONE RISERVATA